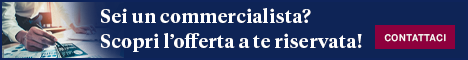
Il Tribunale di Monza, con due provvedimenti del 12 ottobre e 13 maggio 2015, ha affermato la non riconoscibilità del trust autodichiarato in quanto non conforme al tipo negoziale cui fa riferimento l’articolo 2 della Convenzione dell’Aja che richiede una dissociazione tra la figura del disponente e del trustee ed altresì perché in violazione della la regola donner et retenir ne vaut di cui al citato articolo. Afferma inoltre la non riconoscibilità del trust interno in quanto l’Italia, ratificando la Convenzione, non ha esercitato il potere discrezionale conferito dall’articolo 13 e quindi non ha inteso vincolarsi al riconoscimento di trust a carattere meramente interno.
1. Premessa La clausola statutaria di prelazione si applica nel caso di conferimento in società di una partecipazione sociale? La questione, come è noto, è dibattuta, anche in ragione del fatto che il legislatore non ha espressamente regolato in maniera esplicita la materia, per cui la clausola di prelazione (la cui legittimità è, in sé, indiscussa) resta soggetta alle disposizioni dettate in generale per le limitazioni alla circolazione delle partecipazioni, contenute nell'art. 2355-bis c.c. per la s.p.a. e nell'art. 2469, co. 1, c.c. per la s.r.l. Ciò stante, la risposta al quesito posto deve essere cercata, anzitutto, nella formulazione in concreto della clausola statutaria di prelazione per verificare quale ne sia l'effettivo ambito di applicazione e, quindi, se essa «copra» anche la fattispecie in esame. A tal proposito è opportuno ricordare che, secondo un orientamento consolidato, i criteri ermeneutici da privilegiare nell'interpretazione delle clausole statutarie sono quelli oggettivi [1], in ragione del fatto che le regole di funzionamento della società non esauriscono la loro operatività nei rapporti intersoggettivi fra i soci che hanno sottoscritto l'originario atto costitutivo o che hanno fatto ingresso nella compagine sociale in un momento successivo, bensì riverberano i loro effetti nei confronti dei terzi, che con la società (o con i suoi soci) entrano in contatto durante societate[2]. Di qui la necessità di evitare il ricorso a canoni interpretativi che, facendo riferimento alla volontà storicamente perseguita dai soci all'atto della costituzione della società, evochino fatti o circostanze che non siano facilmente apprezzabili dall'esterno. E', poi, innegabile che la lettura che si dia di una clausola statutaria ed il richiamo ai principi regolatori della materia risentano inevitabilmente dell'impostazione dogmatica dell'interprete, delle scelte di fondo che egli opera in ordine a questioni che rappresentano un prius rispetto all'attività ermeneutica, per cui qualunque soluzione venga prospettata è inevitabilmente contrassegnata da un margine di discrezionalità (sia pure tecnica) e di soggettività. In particolare, le risposte al quesito posto sono basate su una differenza di valutazione degli interessi in gioco e conducono spesso ad esiti interpretativi diversi a seconda che si tratti di una prelazione propria ovvero impropria[3] . 2. Gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza Come già accennato, la questione è tutt'ora dibattuta; anzi, può dirsi che sull'argomento è riscontrabile una netta spaccatura fra la posizione assunta dalla dottrina e quello della giurisprudenza. a) La prima, specialmente (ma non esclusivamente) per il caso che si tratti di [continua..]