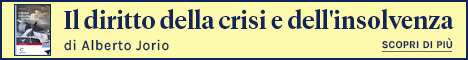
Il saggio illustra i vari profili ed i problemi interpretativi concernenti gli effetti del concordato preventivo per i creditori, individuando la nozione di "creditori anteriori" e gli effetti nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
L'art. 184 l.f. prevede che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla data di pubblicazione sul registro delle imprese del recesso di cui all'art. 161 l.f. (Parole sostituite a quelle "al decreto di apertura della procedura di concordato, dell'art. 33 lett. g) del DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134"), ma che, tuttavia, essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Il secondo comma stabilisce, poi, che, salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Quindi, sulla base della norma qui in commento, nel caso in cui il concordato venga omologato, tutti i "creditori anteriori" alla data di tale pubblicazione, anche nel caso in cui non si fossero pronunciati sulla proposta del debitore o si fossero espressi con un voto contrario, sono obbligati a sottostare a quanto prevede il piano. Si tratta di quello che, tradizionalmente, era stato definito il c.d. effetto esdebitatorio del concordato. Tuttavia, oggi che il piano concordatario può avere anche un contenuto diverso dalla mera riduzione dei crediti, si ritiene che parlare di "effetto esdebitatorio" sia improprio, soprattutto avuto riguardo a quei concordati che, in concreto, prevedono una mera dilazione o altre forme di soddisfazione dei creditori diverse da un mero stralcio in termini monetari[1]. La ratio di tale effetto è da ricercare nei principi economici "che impongono che anche in presenza di grave crisi d'impresa si attui il rapido reinserimento del debitore nel contesto socio economico a tutto vantaggio della produttività e nel rispetto delle regole del mercato[2]. Ci si è interrogati in ordine alla natura giurìdica di tale effetto. Fermo il fatto che la parte di debito eccedente la percentuale non viene estinta dal concordato, è invece in discussione a quale istituto debba essere assimilata la riduzione operata in sede concordataria: vi è infatti chi la riconduce all'istituto della remissione del debito ex art. 1236 c.c., operante solo tra creditore e debitore concordatario[3], oppure chi la accomuna ad un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c[4], oppure ancora chi ritiene che tra creditore e debitore intervenga un pactum de non petendo per la parte eccedente la percentuale[5] o, ancora, chi riconduce l'effetto estintivo del decreto di omologa al venir meno dell'azione in senso sostanziale[6] che alcuni[7] ritengono operata dal provvedimento di omologazione, che estinguerebbe parzialmente il credito, non con efficacia erga omnes, bensì solo nei confronti del debitore[8]. E' altresì dubbio se il momento al quale collegare l'effetto "esdebitatorio" previsto dall'art. 184 l.f. sia da identificarsi nell'emissione del decreto di omologa provvisoriamente esecutivo, oppure nel momento in cui [continua..]